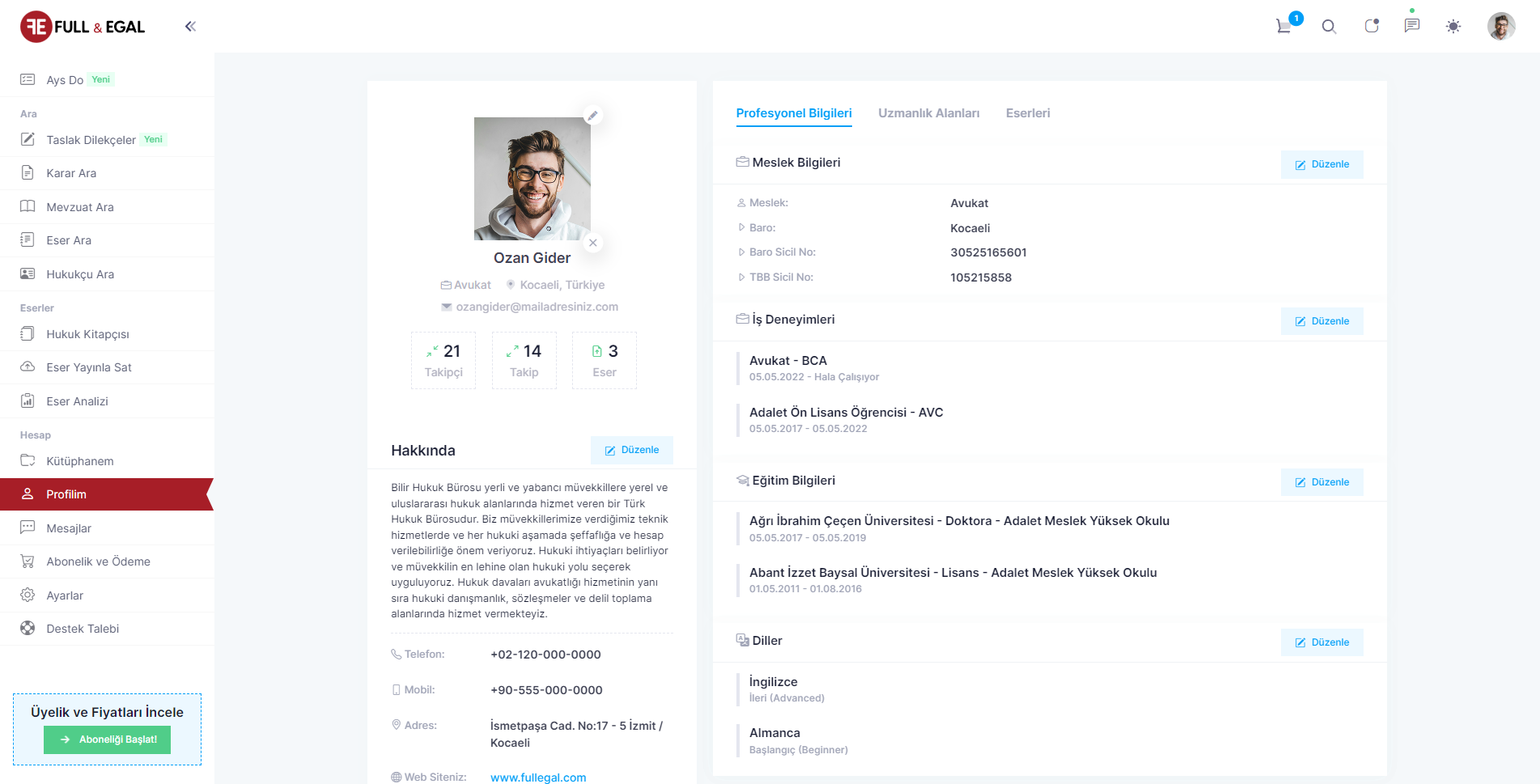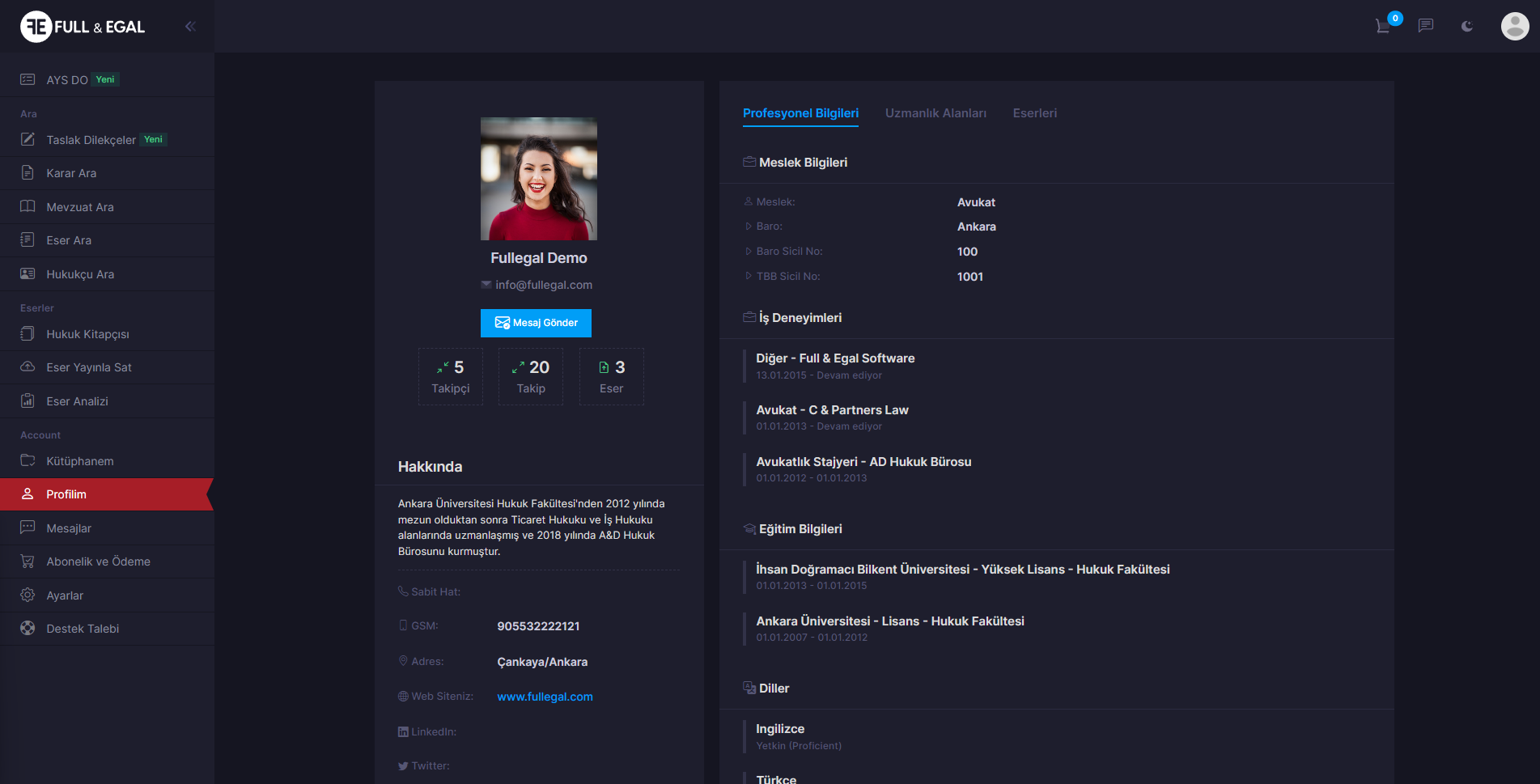Conclusioni dell avvocato generale
1 Quella presente è una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Corte suprema federale in materia tributaria). Detta Corte nutre dubbi in ordine alla validità del regolamento con il quale il Consiglio ha sospeso, all'epoca della guerra nella ex Iugoslavia, le concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione fra la Comunità e la Iugoslavia. L'attrice e appellante nella causa principale, la A. Racke GmbH & Co. (in prosieguo: la «Racke»), è un importatore di vino che importava vino dalla Serbia beneficiando così delle tariffe preferenziali sulle importazioni di vino dalla Iugoslavia fino al momento dell'adozione del regolamento controverso da parte del Consiglio. La Racke lamenta che l'accordo di cooperazione con la Iugoslavia non permetteva al Consiglio di sospenderne l'applicazione e che la decisione presa in tal senso non era conforme a talune norme di diritto internazionale generale. Pertanto, secondo la Racke, il regolamento del Consiglio (1) che sospende le concessioni commerciali era invalido. Gli argomenti si concentrano in particolare su alcune norme di diritto internazionale consuetudinario contenute anche nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, tra le quali il principio pacta sunt servanda e la regola per la quale si può porre fine ad un trattato, a talune condizioni, a seguito di un mutamento fondamentale di circostanze (la clausola rebus sic stantibus (2)). Il caso in esame solleva pertanto la nuova questione se sia possibile per un singolo far valere norme di diritto internazionale generale contro una decisione di sospendere l'applicazione di un accordo internazionale.
Sfondo normativo
L'accordo di cooperazione
2 L'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: l'«accordo di cooperazione») è stato firmato a Belgrado il 2 aprile 1980 e concluso, per conto della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 24 gennaio 1983, n. 314 (3). Si trattava di un cosiddetto accordo misto, di cui erano parti anche gli Stati membri, a fianco della Comunità.
3 In base al suo art. 1, l'accordo di cooperazione si prefiggeva di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: la «RSFI») e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo sarebbero state emanate disposizioni e sarebbero state realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, tecnica e finanziaria, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale.
4 Il titolo I dell'accordo si occupava della cooperazione tecnica, economica e finanziaria, il titolo II degli scambi commerciali, il Titolo III delle disposizioni relative alla zona franca istituita con gli accordi di Osimo e il Titolo IV della cooperazione nel settore della manodopera. Il Titolo V conteneva disposizioni generali e finali.
5 Per quanto riguarda gli scambi commerciali, l'art. 22 dell'accordo di cooperazione stabiliva un regime tariffario preferenziale sulle importazioni di vini di uve fresche originari della Iugoslavia. La disposizione di base, come emendata dal protocollo aggiuntivo all'accordo di cooperazione, del 1987 (4), era l'art. 22, quarto comma:
«Per i vini di uve fresche delle sottovoci 22.05 C I e C II della Tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono aboliti secondo le modalità fissate all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo aggiuntivo che stabilisce un nuovo regime commerciale. Questa disposizione si applica nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 545 000 ettolitri. Per i quantitativi importati oltre detto contingente, la Comunità applica il dazio della Tariffa doganale comune».
6 Fra le disposizioni generali e finali dell'accordo di cooperazione, particolare rilievo aveva l'art. 60, il quale stabiliva:
«La durata dell'accordo è illimitata.
Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica».
Per contro, l'accordo di cooperazione non conteneva alcuna disposizione che prevedesse la sospensione della sua applicazione.
La sospensione e la cessazione dell'accordo di cooperazione
7 Nell'anno 1991 scoppiava la guerra in Iugoslavia. La Comunità e i suoi Stati membri tentavano di svolgere un ruolo attivo per porre termine al conflitto. Nel mese di novembre veniva adottata la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 11 novembre 1991, 91/586/CECA/CEE, recante sospensione dell'applicazione degli accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: la «decisione di sospensione») (5).
8 Il preambolo della decisione di sospensione rinvia alle dichiarazioni della Comunità europea e dei suoi Stati membri, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea, che hanno constatato la crisi in Iugoslavia. Esso rinvia altresì alla risoluzione 713 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha espresso la preoccupazione che la continuazione della crisi costituisse una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Nel preambolo inoltre si asserisce che l'appello lanciato il 6 ottobre 1991 dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri per il rispetto dell'accordo di tregua raggiunto il 4 ottobre 1991 all'Aia non è stato inteso. In tale dichiarazione del 6 ottobre 1991 si annunciava la decisione di porre fine agli accordi fra la Comunità e la Iugoslavia se non fosse stato rispettato l'accordo raggiunto il 4 ottobre 1991 tra le parti in conflitto.
9 Nel preambolo inoltre si afferma (6):
«il proseguimento delle ostilità e le loro conseguenze per i rapporti economici e commerciali, tanto tra le Repubbliche della Iugoslavia quanto con la Comunità, costituiscono una modifica radicale delle condizioni nelle quali l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ed i suoi protocolli, nonché l'accordo relativo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono stati conclusi; (...) essi mettono in causa l'applicazione di questi».
10 Il paragrafo 1 della decisione di sospensione stabilisce:
«L'applicazione degli accordi precitati è sospesa con effetto immediato».
La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 novembre 1991 e va considerata pertanto entrata in vigore a partire da tale data.
11 Il Consiglio inoltre adottava, l'11 novembre 1991, il regolamento (CEE) n. 3300/91, recante sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (in prosieguo: il «regolamento di sospensione») (7).
12 Il preambolo del regolamento di sospensione è quasi identico a quello della decisione di sospensione. In esso tuttavia si aggiunge che conviene sospendere con effetto immediato le concessioni commerciali fatte con l'accordo di cooperazione, o a norma di questo, e che conviene evitare che il regolamento colpisca le esportazioni verso la Comunità di prodotti originari della Iugoslavia effettuate prima della data della sua entrata in vigore.
13 L'art. 1 del regolamento di sospensione dispone:
«Le concessioni commerciali fatte con l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia o a norma di questo accordo sono sospese».
14 L'art. 2 stabilisce:
«L'articolo 1 non si applica ai prodotti originari della Iugoslavia esportati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento».
15 Il regolamento di sospensione è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vale a dire il 15 novembre 1991.
16 Il 25 novembre 1991, il Consiglio adottava la decisione 91/602/CEE relativa alla denuncia dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (8). Nel preambolo si fa riferimento all'art. 60 dell'accordo di cooperazione e si asserisce che la situazione in Iugoslavia non consente più di mantenere l'accordo stesso. L'art. 1 stabilisce che l'accordo di cooperazione nonché tutti i protocolli ed atti ad esso relativi sono denunciati. L'art. 2 stabilisce che la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale e notificata dal Presidente del Consiglio alla Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, prendendo effetto il giorno della sua pubblicazione. La decisione è stata pubblicata il 27 novembre 1991.
17 Il 2 dicembre 1991, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3567/91, relativo al regime applicabile alle importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia (9). Nel preambolo si afferma che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno deciso di applicare misure positive selettive a favore delle parti che contribuiscono al progresso verso la pace, e che conviene pertanto concedere a queste parti, con una decisione autonoma della Comunità, il beneficio di disposizioni commerciali essenzialmente equivalenti a quelle dell'accordo di cooperazione sospeso dalla Comunità. Il regolamento pertanto accordava alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia e Slovenia concessioni commerciali equivalenti a quelle dell'accordo di cooperazione, a decorrere dal 15 novembre 1991, ma tali concessioni non comprendevano le importazioni di vino.
18 Una disciplina analoga fu adottata nel 1992, con l'emanazione del regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 545, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (10). Il preambolo di tale regolamento fa nuovamente riferimento a misure positive selettive, consistenti nel beneficio di disposizioni commerciali sostanzialmente equivalenti a quelle dell'accordo di cooperazione. In esso inoltre si dichiara che è opportuno mantenere tali misure nel 1992, completarle per alcuni prodotti industriali ed estenderle ad alcuni prodotti agricoli. L'art. 6 del regolamento dispone una riduzione dei dazi doganali all'importazione per i vini di uve fresche, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 545 000 hl. Il regolamento è stato applicato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 febbraio 1992, n. 547, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia e Slovenia e delle Repubbliche iugoslave di Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (11).
19 Il 1_ giugno 1992, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 1432/92, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (12).
La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
20 La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (in prosieguo: la «convenzione di Vienna» o la «convenzione») (13) venne aperta alla firma a Vienna il 23 maggio 1969, a seguito della positiva conclusione della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati. La convenzione entrò in vigore il 27 gennaio 1980, dopo il deposito, da parte del Togo, del 35_ strumento di ratifica o adesione (14). La Comunità non è parte della convenzione, né di fatto potrebbe diventarlo dal momento che l'adesione è riservata solo agli Stati (artt. 81 e 83 della convenzione). Un'adesione da parte della Comunità sarebbe in ogni caso priva di effetti dal momento che la convenzione si applica soltanto ai trattati fra Stati (art. 1). Come vedremo in seguito, si sostiene che la convenzione è nondimeno rilevante in quanto espressione di regole di diritto internazionale consuetudinario vincolanti per la Comunità. Esiste una seconda convenzione di Vienna, relativa al diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o fra organizzazioni internazionali (15). Tale convenzione non è ancora entrata in vigore e non è stata firmata dalla Comunità. Le sue disposizioni coincidono ampiamente con quelle della convenzione del 1969, alla quale prevalentemente mi limiterò nel prosieguo.
21 Tutti gli Stati membri della Comunità ad eccezione di Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione alla convenzione di Vienna. Di questi quattro Stati membri, solo il Lussemburgo ha firmato la convenzione (ma non l'ha ancora ratificata).
22 Il principio fondamentale del diritto internazionale dei trattati è espresso nell'art. 26 della convenzione di Vienna, sotto il titolo «Pacta sunt servanda»:
«Ogni trattato in vigore obbliga le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede».
23 La parte V, sezione 3, della convenzione contiene disposizioni relative all'estinzione e alla sospensione dei trattati. La regola principale è che i trattati cessano di essere in vigore o vengono sospesi in forza delle loro disposizioni o per consenso di tutte le parti (artt. 54 e 57). Fra le altre disposizioni di questa sezione, sono rilevanti l'art. 61, relativo alla «Impossibilità sopravvenuta di esecuzione», l'art. 62, sul «Mutamento fondamentale delle circostanze», e gli artt. 65-67, relativi a problemi procedurali.
24 L'art. 61, n. 1, dispone:
«Una parte può invocare l'impossibilità di esecuzione di un trattato come motivo per porvi termine o per recedere da esso se l'impossibilità è conseguenza della scomparsa o della distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato. Se l'impossibilità è temporanea, può essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del Trattato».
25 L'art. 62 recita:
«Mutamento fondamentale delle circostanze
1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto rispetto a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti non può essere invocato come motivo per porre termine al trattato o per recedere da esso a meno che:
a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
b) tale mutamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato.
2. Un mutamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo per porre termine a un trattato o per recedere da esso:
a) se il trattato fissa un confine; o
b) se il mutamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che l'invoca, di un obbligo del trattato ovvero di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi altra parte del trattato.
3. Se una parte può, in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine a un trattato o per recedere da questo, essa può anche invocarlo soltanto come motivo di sospensione dell'applicazione del trattato».
26 L'art. 65 contiene la «Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso o sospensione dell'applicazione di un trattato». L'art. 65, n. 1, dispone che una parte che invoca un motivo di estinzione di un trattato, di recesso da esso o di sospensione della sua applicazione, deve notificare la sua pretesa alle altre parti. La notifica deve indicare la misura proposta nei confronti del trattato e le ragioni di essa. L'art. 65, n. 2, prevede un termine non inferiore a tre mesi (salvo casi di particolare urgenza), scaduto il quale, se nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha proceduto alla notifica può adottare la misura proposta. Se viene sollevata un'obiezione, le parti dovranno cercare una soluzione attraverso i mezzi indicati dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite (art. 65, n. 3).
27 L'art. 66 contiene altre disposizioni sulle «Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione». L'art. 67, n. 1, stabilisce che la notifica prevista all'art. 65, n. 1, dev'essere effettuata per iscritto.
28 Citerò anche l'art. 73 della convenzione, relativo ai «Casi di successione di Stati, di responsabilità di uno Stato e di scoppio di ostilità», in base al quale:
«Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano alcuna questione che possa sorgere in ordine ad un trattato a seguito di una successione fra Stati o in ragione della responsabilità internazionale di uno Stato o dello scoppio di ostilità fra Stati».
29 E' generalmente riconosciuto che numerose disposizioni della convenzione di Vienna codificano regole del diritto internazionale consuetudinario. Tuttavia, è anche riconosciuto che, in certa misura, la convenzione costituisce uno sviluppo progressivo che va al di là della consuetudine in essere. Inoltre, non sembra che vi sia accordo su quali disposizioni di preciso rientrino appunto nel diritto internazionale consuetudinario e quali no (16). Tuttavia, tanto il principio pacta sunt servanda quanto la clausola rebus sic stantibus (che permette di tener conto di un mutamento fondamentale delle circostanze) sono universalmente riconosciuti come parte integrante del diritto internazionale consuetudinario. Nelle cause sulla «competenza in materia di pesca» (17) la Corte internazionale di giustizia, riferendosi al principio dell'estinzione di un trattato a causa di un mutamento fondamentale di circostanze, ha dichiarato:
«Questo principio, unitamente alle condizioni ed eccezioni cui è soggetto, è stato sancito nell'art. 62 della convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, che può essere considerata, sotto molti profili, come una codifica del diritto consuetudinario esistente in materia di cessazione di relazioni convenzionali a seguito di un mutamento di circostanze».
Il procedimento principale
30 Nel periodo compreso fra il 6 novembre 1990 e il 27 aprile 1992, la Racke importava vini dalla regione vinicola del Kosovo. Essa poneva tali importazioni in regime di deposito doganale in un magazzino privato di sua proprietà e il 7 maggio 1992 dichiarava le partite messe in libera pratica. In tale occasione, la Racke calcolava il dazio doganale in base all'aliquota preferenziale prevista dall'accordo di cooperazione, che nel frattempo era stato sospeso. Lo Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) di Magonza esigeva allora un dazio supplementare pari alla differenza tra l'aliquota dei dazi doganali per i paesi terzi e l'aliquota preferenziale, dal momento che il vino era stato importato dalla Serbia (avviso di rettifica fiscale del 27 maggio 1992, confermato dalla decisione pronunciata il 27 agosto 1993 sull'opposizione proposta dalla Racke). La Racke contestava tale decisione dinanzi al Finanzgericht (Tribunale fiscale) del Land Renania-Palatinato. Il suo ricorso aveva esito positivo riguardo al dazio supplementare per i vini esportati dalla Iugoslavia prima del 15 novembre 1991, ma veniva respinto per il resto. Il Finanzgericht basava il rigetto del ricorso sul regolamento di sospensione affermando che la sospensione, disposta da detto regolamento, delle agevolazioni commerciali convenute, anche prima della denuncia dell'accordo di cooperazione, non sollevava alcun dubbio giuridico. Anzi, la sospensione unilaterale era legittima, dal momento che nella ex Iugoslavia si era verificato un mutamento fondamentale delle circostanze. La guerra in Iugoslavia rappresentava un valido motivo di sospensione: tale motivo, in base al diritto internazionale, consentiva il recesso da un trattato, quanto meno attraverso una sospensione, la quale appare come un intervento più lieve rispetto alla denuncia successiva.
31 La Racke impugnava allora la sentenza del Finanzgericht, per motivi di diritto, dinanzi al Bundesfinanzhof. Essa contestava la validità del regolamento di sospensione e chiedeva che le disposizioni dell'accordo di cooperazione fossero applicate fino al 27 maggio 1992, data in cui la denuncia di detto accordo era divenuta effettiva.
32 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof espone i propri dubbi sulla validità del regolamento di sospensione. Esso sottolinea che tale regolamento costituiva, all'epoca dei fatti, la base giuridica per il dazio supplementare reclamato dallo Hauptzollamt, dato che la denuncia dell'accordo di cooperazione non era ancora effettiva e il commercio con la Serbia e il Montenegro non era ancora vietato. Esso ammette di essere incline a ritenere che il carattere vincolante del regolamento di sospensione non può essere messo in discussione in base al diritto internazionale. Tuttavia, i dubbi esistenti al riguardo, in particolare sulla legittimità in base al diritto internazionale della sospensione unilaterale dell'accordo di cooperazione, non possono essere ignorati.
33 Il Bundesfinanzhof esprime inoltre le seguenti considerazioni. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'incompatibilità di un atto comunitario con una disposizione di diritto internazionale può inficiare la validità di tale atto solo se la Comunità è vincolata da tale disposizione e se questa è idonea a conferire ai cittadini comunitari diritti che essi possono far valere davanti ai giudici. Tali condizioni sembrano essere soddisfatte relativamente alle concessioni tariffarie definite dall'art. 22 dell'accordo di cooperazione, in esame nel caso di specie. Ciò solleva la questione della legittimità della sospensione dell'accordo di cooperazione, questione cui non è possibile rispondere affermativamente senza alcuna riserva. La Comunità è vincolata dalle norme di diritto internazionale generale così come espresse, per esempio, nella convenzione di Vienna. L'accordo di cooperazione non prevedeva la possibilità di una sospensione e la sospensione a seguito di un mutamento fondamentale, non previsto dalle parti, delle circostanze in essere al momento della conclusione dell'accordo (la clausola rebus sic stantibus) è ammessa solo a condizioni rigorose, cioè che la presenza di tali circostanze costituisse una base essenziale per la conclusione del trattato e che il mutamento di dette circostanze modifichi radicalmente la portata degli obblighi che devono essere ancora adempiuti in forza del trattato.
34 Il Bundesfinanzhof ritiene che la prima condizione sia soddisfatta, ma nutre dubbi riguardo alla seconda. Non è ovvio che il mutamento verificatosi a seguito dello smembramento della Iugoslavia e dello scoppio delle ostilità potesse radicalmente modificare la portata degli obblighi derivanti da un accordo di natura essenzialmente economica. Inoltre, il diritto internazionale prescrive anche formalità procedurali, fra cui la notifica e l'osservanza di un preavviso, salvo in caso di particolare urgenza. Ci si può pertanto domandare se possa ammettersi una sospensione immediata senza preavviso, se sussistesse una particolare urgenza e se eventuali irregolarità procedurali possano essere state sanate dal decorso del tempo prima della data dello sdoganamento rilevante nel caso di specie.
35 Se il regolamento di sospensione è invalido, si pone la questione del trattamento da riservare alle importazioni che sarebbero state ricomprese in un contingente tariffario comunitario aperto per il 1992 se l'accordo di cooperazione fosse stato ancora applicato. Dal momento che l'ultimo contingente annuo per la Iugoslavia era già esaurito per importazioni compiute alla fine del 1991, si potrebbero prendere come base le regole sui contingenti contenute nei regolamenti nn. 545/92 e 547/92, relativi a prodotti originari della Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Montenegro (18).
36 Di conseguenza, il Bundesfinanzhof ha deferito alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia valido il regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1991, n. 3300, recante sospensione delle concessioni commerciali previste dall'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (...).
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1): quali conseguenze debbano trarsi dall'invalidità in relazione ad un'operazione di sdoganamento, effettuata all'inizio del maggio 1992 e avente ad oggetto vini di provenienza serba importati nel periodo compreso fra la metà del novembre 1991 e l'aprile 1992 e posti in deposito doganale.
Se siano al riguardo applicabili le agevolazioni doganali connesse ai contingenti aperti nel 1992 per vini provenienti dalla ex Iugoslavia, ad eccezione della Serbia».
37 Prima di volgermi a trattare la prima questione, tenuto conto del carattere inedito dei problemi sollevati e del fatto che è in gioco la validità di un regolamento, può essere opportuno riassumere i principali argomenti addotti nelle osservazioni presentate nel presente procedimento. Hanno presentato osservazioni scritte e orali la Racke, il Consiglio e la Commissione.
Gli argomenti principali
38 La Racke fa riferimento al principio universalmente riconosciuto pacta sunt servanda, che è limitato, in diritto internazionale, dalla clausola derogatoria rebus sic stantibus. Dal regolamento di sospensione, che si riferisce ad un mutamento radicale di condizioni, risulta chiaramente che il Consiglio ha cercato di far ricorso a tale deroga. La clausola rebus sic stantibus è contenuta nell'art. 62 della convenzione di Vienna, articolo che impone limiti rigorosi e va interpretato restrittivamente e obiettivamente. L'onere della prova incombe alle parti contraenti che invocano la deroga. La convenzione di Vienna contiene inoltre norme procedurali.
39 Secondo la Racke, la Comunità è vincolata dalle disposizioni della convenzione di Vienna, riflettendo quest'ultima il diritto internazionale consuetudinario. Essa fa riferimento alle sentenze della Corte internazionale di giustizia nelle cause sulla «competenza in materia di pesca», precedentemente citate. La Racke inoltre sostiene che, in base alla prassi e alla dottrina del diritto internazionale, la sospensione di un trattato dev'essere preceduta da tentativi di raggiungere un accordo.
40 La Racke sostiene che il regolamento di sospensione non soddisfa né i requisiti procedurali della convenzione di Vienna (artt. 65 e 67), né i suoi requisiti sostanziali (art. 62).
41 Sul piano procedurale, la Racke sostiene che il Consiglio ha sospeso le concessioni tariffarie senza previa notifica alla RSFI e con effetto immediato. Non esisteva alcun caso di «particolare urgenza», come richiesto dall'art. 65, n. 2, della convenzione per una sospensione immediata. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non aveva ancora imposto un embargo commerciale e non vi erano altri motivi di particolare urgenza. Si potrebbe supporre che, se la Comunità avesse notificato la sua intenzione di sospendere l'accordo di cooperazione, la RSFI vi si sarebbe opposta. Inoltre, è difficile capire perché il Consiglio e gli Stati membri non si siano limitati a denunciare l'accordo di cooperazione (continuando quindi ad applicare l'accordo stesso sino allo scadere del preavviso di sei mesi). La Racke sottolinea che le norme procedurali della convenzione di Vienna sono regole fondamentali di diritto internazionale, la cui violazione è sufficiente a invalidare il regolamento di sospensione.
42 Sul piano sostanziale, la Racke asserisce che non vi era alcun motivo per ricorrere alla clausola rebus sic stantibus.
43 Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof fa riferimento allo «smembramento» della Iugoslavia. Ora, secondo la Racke, in base al diritto internazionale non si configura uno smembramento della Iugoslavia poiché essa continua ad esistere in forma ridotta (Serbia e Montenegro). In ogni caso, nel regolamento di sospensione il Consiglio non ha fatto menzione di alcuno smembramento.
44 Il regolamento fa sì riferimento al «proseguimento delle ostilità» in Iugoslavia, ma questo, a detta della Racke, non costituisce un mutamento fondamentale di circostanze. In molti Stati vi sono ostilità, anche in Stati membri della Comunità. L'assenza di tali ostilità non costituisce una «base essenziale per il consenso delle parti» [art. 62, n. 1, lett. a) della convenzione di Vienna]. Non vi era guerra alcuna con la Iugoslavia, a dire il vero non vi era neppure una guerra all'interno della Iugoslavia, ma soltanto dei conflitti fra gruppi etnici che rivendicavano l'autodeterminazione.
45 Il regolamento di sospensione fa riferimento alle conseguenze della prosecuzione delle ostilità sulle relazioni economiche e commerciali fra le repubbliche della Iugoslavia. Per la Comunità, tuttavia, tali conseguenze non costituirebbero un mutamento fondamentale di circostanze.
46 Inoltre, il regolamento di sospensione fa menzione delle conseguenze sui rapporti commerciali ed economici con la Comunità. La Racke sostiene che tali conseguenze erano all'epoca molto limitate. Il commercio era ancora possibile, come dimostrato dalle importazioni di vino in questione. Il regolamento di sospensione non precisa queste «conseguenze», e spetta al Consiglio dimostrare quali esse siano, tenendo a mente che esse dovrebbero consistere in un mutamento fondamentale di circostanze che, a loro volta, avevano costituito una base essenziale per il consenso delle parti.
47 Secondo la Racke l'accordo di cooperazione era stato sospeso per ragioni politiche: si trattava di un mezzo per esercitare pressioni sulle parti in conflitto perché osservassero accordi di tregua. Benché comprensibile da un punto di vista politico, la sospensione non rispondeva per questo alle condizioni della clausola rebus sic stantibus. Quest'ultima richiede anche che «tale mutamento abbia per effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato». La Racke nega l'esistenza di un simile mutamento. L'accordo di cooperazione era in primo luogo un accordo commerciale, finalizzato agli interessi dei soggetti economici, e il commercio con la Iugoslavia a quell'epoca continuava.
48 La Racke conclude quindi che nessuno dei requisiti procedurali e sostanziali per il ricorso alla clausola rebus sic stantibus era soddisfatto.
49 Il Consiglio sostiene la validità del regolamento di sospensione. Esso ricorda in primo luogo il pertinente sfondo normativo. Il regolamento di sospensione era accompagnato dalla decisione di sospensione, adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Tale decisione precede il regolamento sia dal punto di vista logico sia da quello giuridico. L'adozione del regolamento di sospensione era necessaria perché le concessioni tariffarie previste dall'accordo di cooperazione erano state applicate tramite regolamenti. Pertanto, lo sfondo normativo non consiste in un accordo internazionale ancora in vigore e in un regolamento comunitario unilateralmente sospensivo delle agevolazioni tariffarie. Esso consiste invece in un accordo internazionale la cui esecuzione era stata sospesa a livello internazionale; le sue disposizioni, pertanto, non facevano più sorgere diritti in capo ai singoli nel momento in cui il regolamento di sospensione era stato adottato.
50 Il Consiglio sostiene che la Racke e il Bundesfinanzhof hanno una concezione errata dei rapporti fra il diritto internazionale e il diritto comunitario. Anche se la decisione di sospensione fosse invalida in base al diritto internazionale, ciò non implicherebbe che l'accordo di cooperazione continuerebbe ad essere applicato. Il diritto internazionale non impone forme specifiche di riparazione; esso non impone, in particolare, una rimessa in vigore dell'accordo in questione. Una pretesa violazione del diritto internazionale può mettere in moto una procedura fra le parti tale da sfociare in una rimessa in vigore dell'accordo, ma può anche sfociare in un risarcimento per la parte lesa oppure in una ritorsione, da parte di quest'ultima, attraverso misure di rappresaglia. Nel caso di specie, non era stata avviata alcuna procedura del genere e, anche se ciò fosse avvenuto, una nuova applicazione dell'accordo di cooperazione sarebbe stata improbabile. In caso di grave deterioramento delle relazioni fra le parti contraenti di un trattato, ciascuna delle parti dispone di un margine di scelta politica tra le varie soluzioni possibili in base al diritto internazionale. Non è pertanto necessario che la Corte, nell'esaminare la validità del regolamento di sospensione, prenda in considerazione il problema di stabilire se la sospensione dell'accordo di cooperazione fosse conforme o meno al diritto internazionale: l'accordo, in ogni caso, ha