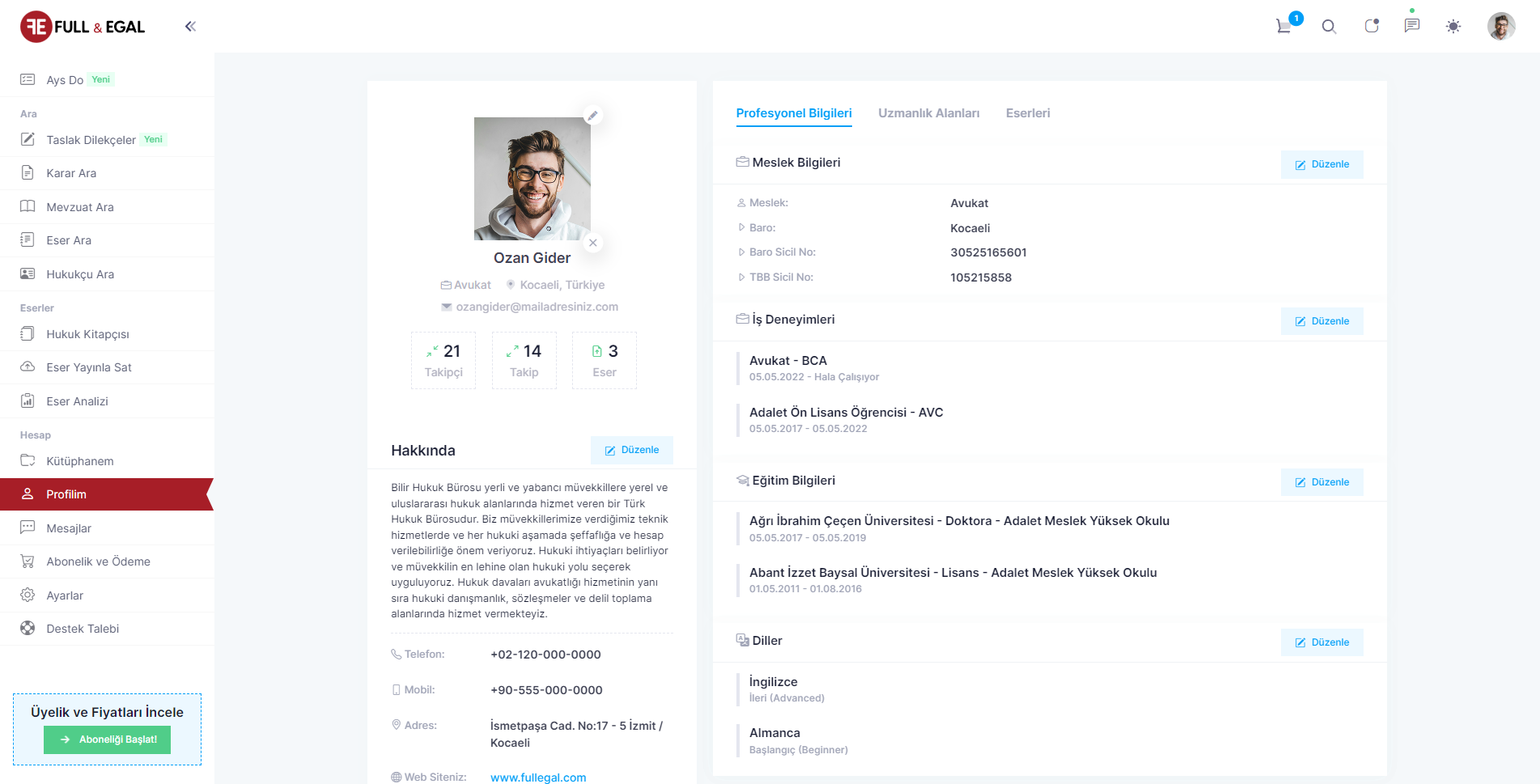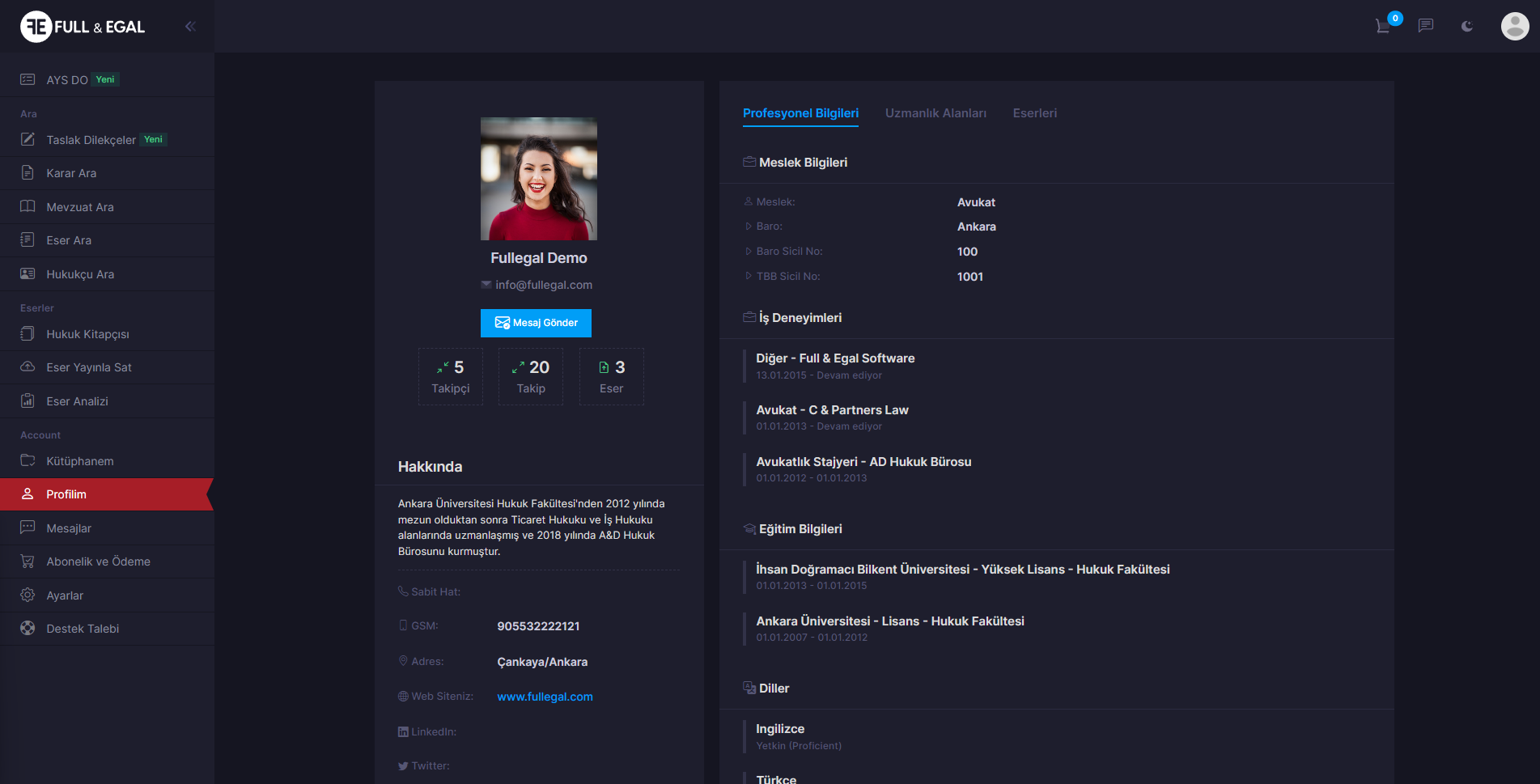Conclusioni dell avvocato generale
1 Il Tribunale di Genova formula, nell'ambito delle presenti cause riunite, due questioni pregiudiziali vertenti sull'incidenza del diritto comunitario, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, su determinati presupposti per l'esercizio del diritto alla ripetizione di tributi indebitamente riscossi dall'Amministrazione italiana. In concreto, si tratta del rimborso di somme versate da alcune imprese in assolvimento di un tributo nazionale contrario alla normativa comunitaria.
Fatti, cause principali e questioni pregiudiziali
2 Nei procedimenti C-279/96 e C-281/96 le ricorrenti sono società che, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (in prosieguo: il «DPR n. 641/1972»), hanno versato all'erario italiano, nel corso di diversi anni, vari importi a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese. Nel procedimento C-280/96 la ricorrente è l'Amministrazione tributaria italiana, condannata alla restituzione di siffatte somme a favore di un'altra impresa.
3 Dopo la pronuncia della sentenza della Corte 20 aprile 1993, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni (1) (in prosieguo: la «sentenza Ponente Carni»), in risposta a varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (2), il legislatore italiano aboliva la tassa annuale e riduceva a 500 000 LIT l'importo dell'iscrizione delle società nel registro (3).
4 Per parte loro i giudici italiani dichiaravano anch'essi l'incompatibilità della tassa annuale con il diritto comunitario (4) e, conseguentemente, il carattere indebito dei versamenti effettuati a tale titolo.
5 Dopo aver chiesto invano all'Amministrazione italiana la restituzione delle tasse indebitamente versate, le società ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Genova di condannare il Ministero delle Finanze al rimborso delle medesime. Nel caso dell'impresa Marine Insurance Consultants Srl, il presidente del Tribunale ha accolto la detta domanda con decreto 21 luglio 1995, oggetto di opposizione da parte dell'Amministrazione tributaria.
6 Prima di pronunciarsi in via definitiva sulle controversie in corso, il Tribunale di Genova ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario una normativa nazionale che preveda un termine decadenziale per l'esercizio di un'azione a tutela di un diritto di rilevanza comunitaria decorrente da un momento antecedente rispetto alla corretta e compiuta trasposizione nell'ordinamento interno della direttiva che ha riconosciuto tale diritto.
2) Se sia compatibile con l'ordinamento comunitario la previsione di una modalità reintegrativa delle ragioni del soggetto che sia stato riconosciuto leso nel proprio diritto e al quale venga attribuito il rimborso delle somme richieste, con modalità di quantificazione diverse e meno favorevoli rispetto a quelle previste per le azioni di rimborso fra privati, e sostanzialmente determinate con atto proveniente dallo stesso soggetto statuale che ha determinato con il proprio inadempimento la lesione del diritto medesimo».
Sulla prima questione pregiudiziale
7 Data l'analogia di tale questione pregiudiziale con quelle proposte dal Tribunale di Genova nel procedimento C-231/96, Edis, sulle quali presento parimenti in data odierna le mie conclusioni, sarebbe stato possibile limitare il contenuto delle presenti osservazioni a un mero rinvio al testo delle altre. Tuttavia, dal momento che i procedimenti non sono stati riuniti e che i giudici di rinvio così come le parti nelle cause principali sono diversi, ho preferito riproporre almeno le medesime osservazioni fondamentali per entrambi i giudizi, aggiungendo, ove opportuno, alcuni riferimenti specifici o richiamando le conclusioni nella causa Edis con riferimento a determinati elementi in comune.
8 Il giudice a quo si chiede se sia compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale la quale preveda, in materia di azioni di ripetizione di indebito fiscale, quale dies a quo del termine di decadenza triennale la data di pagamento del tributo, quando la direttiva comunitaria applicabile a quest'ultimo non era stata correttamente trasposta in diritto nazionale.
9 Le osservazioni scritte presentate dalle imprese ricorrenti, dalla Commissione e da vari Stati membri sono incentrate sull'incidenza della sentenza della Corte 25 luglio 1991, Emmott (5), sul detto problema. Come è noto, in questa sentenza la Corte ha dichiarato: «(...) fino al momento della trasposizione corretta della direttiva, lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni della direttiva e che un termine di ricorso del diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento» (6).
10 Vero è che la portata della sentenza Emmott è stata comunque successivamente ridotta dalla Corte, la quale ha sottolineato che è possibile richiamarsi a tale pronuncia solo quando si verifichino le medesime circostanze particolari presenti in quella fattispecie. Nelle sentenze 27 ottobre 1993, Steenhorst-Neerings (7), e 6 dicembre 1994, Johnson (8), la Corte ha confermato l'applicabilità dei termini nazionali di prescrizione a domande di importi dovuti a titolo di prestazioni previdenziali, derivanti dall'applicazione di determinate direttive, anche quando queste ultime non erano state ancora correttamente trasposte in diritto nazionale.
11 Contemporaneamente allo svolgimento del presente procedimento pregiudiziale, la Corte ha pronunciato le sentenze Haahr Petroleum (9) nonché Texaco e Olieselskabet Danmark (10), nelle quali ha respinto, ancora una volta, l'applicazione del principio giurisprudenziale stabilito dalla sentenza Emmott. In entrambi i casi, una domanda di restituzione - fondata sulla violazione dell'art. 95 del Trattato - era stata rigettata dalle autorità danesi, in forza di una norma nazionale ai sensi della quale l'azione giurisdizionale mirante alla restituzione di un indebito fiscale cade in prescrizione alla scadenza di un termine quinquennale, decorrente dalla data del pagamento. La Corte ha ribadito che, anche se la detta norma impediva la ripetizione totale o parziale dei citati tributi, la sua applicazione in entrambi i casi non era contraria al diritto comunitario.
12 In ultimo, due mesi prima dell'udienza nel presente procedimento, la Corte ha pronunciato la sentenza 2 dicembre 1997, Fantask e a. (11), molto importante ai fini della risposta che occorre ora formulare, giacché si trattava di una causa i cui elementi di diritto e di fatto sono analoghi a quelli della presente. Oggetto della sentenza Fantask era la restituzione di indebiti relativi:
- allo stesso tipo di imposta nazionale (imposta danese per l'iscrizione di società nell'apposito registro);
- allo stesso tipo di incompatibilità con il diritto comunitario (nel caso specifico, con la direttiva 69/335) della norma nazionale disciplinante il tributo;
- allo stesso conflitto dei termini di decadenza o di prescrizione nazionali (cinque anni, secondo la legislazione nazionale, decorrenti dal giorno del pagamento dell'imposta).
13 Così come nel presente caso, nella causa Fantask il giudice nazionale, posto di fronte a una controversia avente le suesposte caratteristiche, chiedeva alla Corte «(...) se il diritto comunitario vieti ad uno Stato membro di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione della direttiva un termine di prescrizione nazionale fintantoché tale Stato membro non abbia correttamente attuato tale direttiva». Le allegazioni delle società ricorrenti nella causa principale e della Commissione si basavano parimenti sulla giurisprudenza Emmott, alla cui applicazione si opponevano i governi intervenienti nel procedimento pregiudiziale.
14 La Corte ha optato, una volta di più, per quest'ultima soluzione, ribadendo il ragionamento al quale ho fatto riferimento.
15 In primo luogo, come principio generale, essa ha ricordato che, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali per la ripetizione dell'indebito, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.
16 In secondo luogo, dopo aver sottolineato la compatibilità con il diritto comunitario della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, che tutela al tempo stesso il contribuente e l'amministrazione, essa ha posto in risalto che questi termini non possono essere considerati tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario, anche se, per definizione, il loro spirare comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita. In concreto, il termine quinquennale fissato dal diritto danese era ragionevole e si applicava indifferentemente ai ricorsi basati sul diritto comunitario e a quelli basati sul diritto interno.
17 In terzo luogo, essa ha nuovamente escluso l'applicabilità a questo tipo di controversie della soluzione fornita nella sentenza Emmott, che era giustificata dalle circostanze tipiche di detta causa, nelle quali la decadenza arrivava a privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù di una direttiva comunitaria.
18 Infine, la Corte ha concluso che, «(...) allo stato attuale, il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro che non ha attuato correttamente la direttiva di opporre alle azioni dirette al rimborso di tributi riscossi in violazione di tale direttiva un termine di prescrizione nazionale che decorra dalla data di esigibilità dei tributi di cui trattasi, qualora tale termine non sia meno favorevole per i ricorsi basati sul diritto comunitario di quello dei ricorsi basati sul diritto interno e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario».
19 Stanti la chiarezza della posizione ora illustrata e l'evidente analogia delle circostanze di fatto e di diritto tra la causa Fantask e la presente, la Commissione ha rinunciato in udienza a difendere la sua precedente tesi e ha ammesso che la questione era stata definitivamente risolta con la pronuncia della sentenza Fantask. Le ricorrenti nella causa principale, al contrario, hanno cercato, nella stessa sede (12), di porre in evidenza l'esistenza di elementi di differenziazione tra gli ordinamenti giuridici danese e italiano che inficiassero l'applicazione della giurisprudenza Fantask al presente caso.
20 A mio parere, questo tentativo è fallito. In primo luogo, per il fatto che il suo punto di partenza era errato: più che scoprire asserite differenze tra il caso Fantask e il presente, sarebbe stato invece necessario dimostrare l'analogia di circostanze tra il caso Emmott e la causa presente, dato che la giurisprudenza successiva alla sentenza Emmott ha insistito sulla specificità dei dati di quella fattispecie, determinanti per la soluzione adottata. A questo proposito, il governo britannico ha sottolineato in udienza che - tra le altre circostanze - in quel caso la pubblica amministrazione di tale Stato membro aveva esercitato pressioni affinché la signora Emmott non presentasse ricorso. Al contrario, nulla ha impedito alle società italiane l'esercizio del loro diritto di ricorso avverso i corrispondenti atti d'imposizione fiscale (13).
21 In secondo luogo, e a prescindere da quanto precede, le asserite differenze tra l'una e l'altra legislazione nazionale sono irrilevanti per quanto riguarda le ripercussioni della giurisprudenza Fantask su questo caso. Sia che si tratti di un termine quinquennale o triennale, sia che esso venga stabilito da una norma generale o da una speciale dettata per una determinata categoria di tributi, sia che abbia avuto luogo o meno un mutamento giurisprudenziale sull'interpretazione della detta norma preesistente, il punto rilevante è che la Corte ha confermato che il termine - di cinque o di tre anni - di decadenza opponibile alle azioni di ripetizione di indebito fiscale, basate su ragioni di diritto comunitario, può cominciare a decorrere dal momento in cui i tributi sono stati assolti, e non dal momento in cui lo Stato membro ha trasposto correttamente la direttiva nel diritto nazionale.
22 Questa affermazione - che, ovviamente, presuppone l'inesistenza di norme di diritto comunitario che regolino la materia e l'esistenza di una norma di diritto nazionale che fissi in modo non discriminatorio il termine di decadenza - n