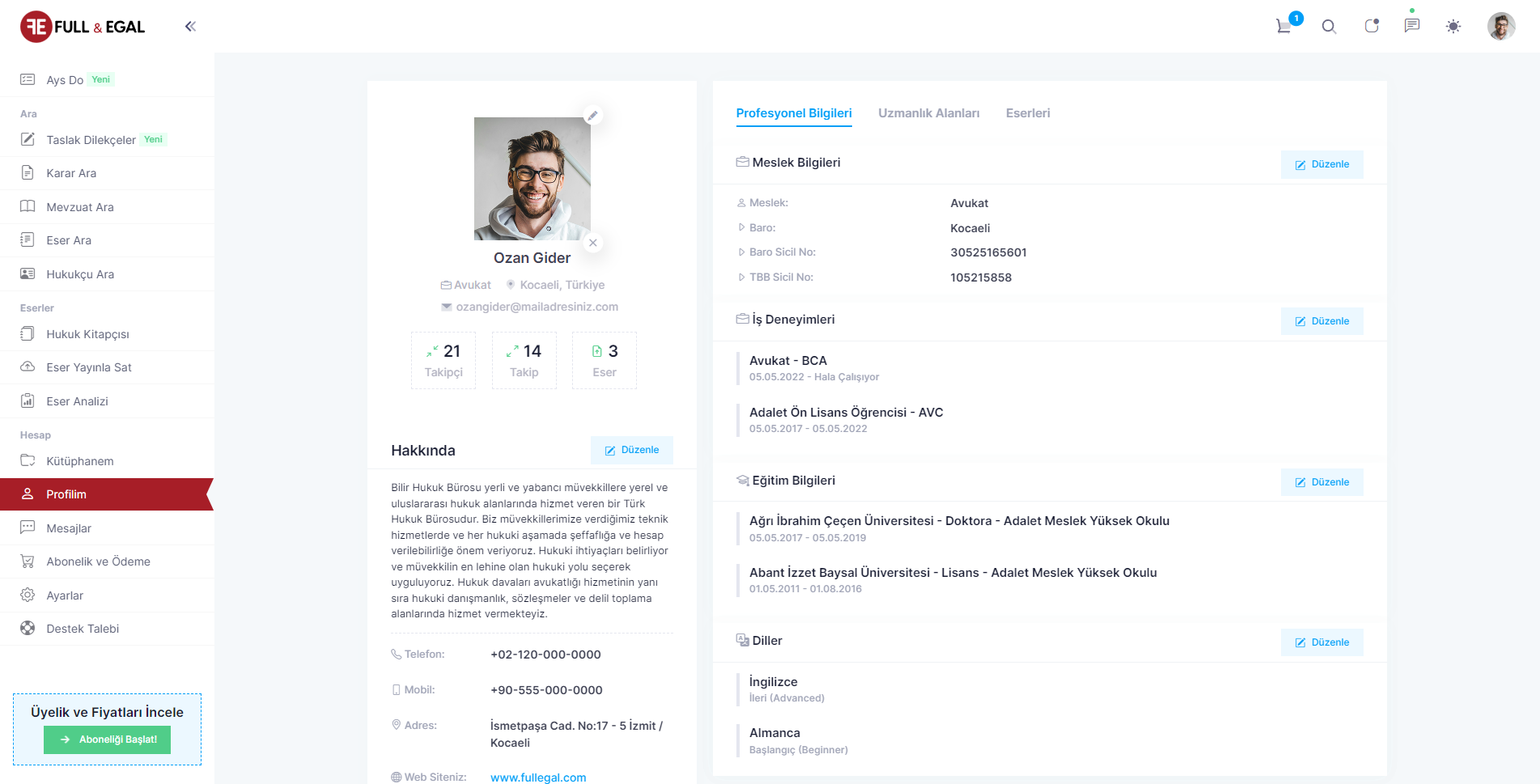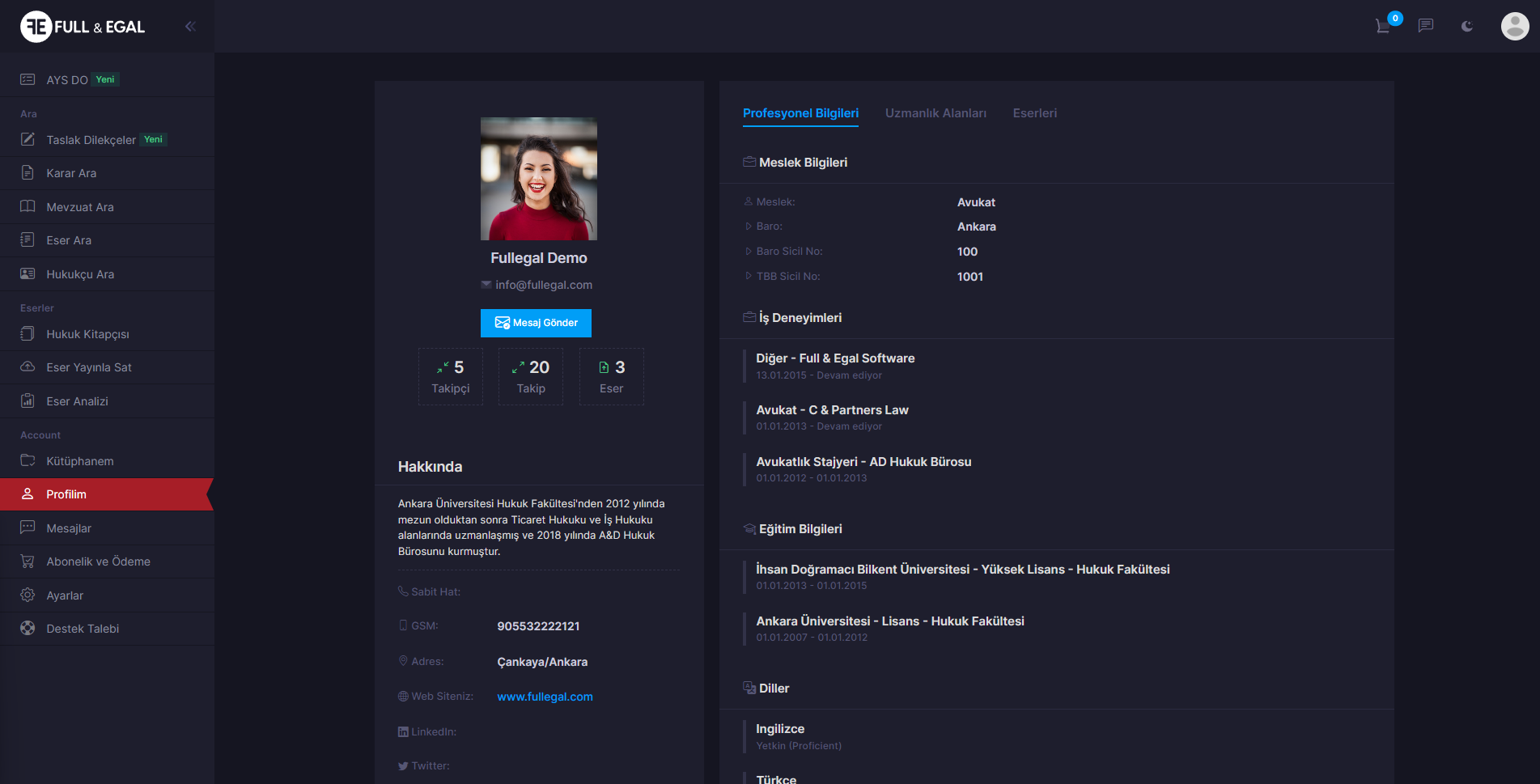CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 17 gennaio 2013 ( 1 )
Causa C‑583/11 P
Inuit Tapiriit Kanatami e a.
contro
Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1007/2009 — Commercio di prodotti derivati dalla foca — Divieto di immissione in commercio nell’Unione europea — Eccezioni per le comunità Inuit — Legittimazione ad agire di persone fisiche e giuridiche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Nozione di “atto regolamentare” e differenziazione rispetto a “atto legislativo” — Mancanza di incidenza diretta o individuale»
I – Introduzione
1.
Le possibilità di tutela giuridica dei singoli rispetto agli atti dell’Unione di portata generale rappresentano da tempo una delle questioni più dibattute del diritto europeo. A partire della sentenza Plaumann ( 2 ) la Corte di giustizia ha fornito in una costante giurisprudenza – prima relativamente all’articolo 173 C(E)E e successivamente all’articolo 230 CE – un’interpretazione relativamente restrittiva della legittimazione diretta ad agire delle persone fisiche e giuridiche. Nonostante alcune critiche, la Corte di giustizia si è attenuta alla suddetta giurisprudenza fino ad oggi, confermandola soprattutto nelle sentenze Unión de Pequeños Agricultores ( 3 ) e Jégo‑Quéré ( 4 ).
2.
Non da ultimo come reazione a questa giurisprudenza, nel Trattato di Lisbona si è pervenuti ad una nuova disciplina della legittimazione ad agire dei singoli, entrata in vigore il 1o dicembre 2009. Da allora l’articolo 263, quarto comma, TFUE consente alle persone fisiche e giuridiche anche di proporre un ricorso d’annullamento «contro gli atti regolamentari che l[e] riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
3.
Ovviamente a tutt’oggi l’entità dell’estensione della legittimazione attiva dei singoli operata da quella nuova disciplina è oggetto di accesi dibattiti. Nel presente procedimento di impugnazione la Corte è chiamata a pronunciarsi proprio sulla suddetta questione controversa e, in tale ambito, ad esprimersi soprattutto sull’interpretazione della nozione di «atto regolamentare» ( 5 ). In questo contesto si deve chiarire soprattutto se anche gli atti legislativi dell’Unione europea possano essere annoverati nella categoria degli atti regolamentari.
4.
All’origine della presente controversia è il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea il 16 settembre 2009 ( 6 ). Il suddetto regolamento ha disposto un divieto di immissione in commercio sul mercato interno europeo dei prodotti derivati dalla foca, contro cui ora la Inuit Tapiriit Kanatami, in quanto rappresentante degli interessi degli Inuit canadesi ( 7 ) nonché numerose altre parti – soprattutto produttori o commercianti di prodotti derivati dalla foca – cercano tutela giuridica dinanzi ai giudici dell’Unione.
5.
In primo grado la richiesta della Inuit Tapiriit Kanatami e degli altri ricorrenti non è stata accolta. Il loro ricorso d’annullamento è stato respinto dal Tribunale dell’Unione europea con ordinanza del 6 settembre 2011 ( 8 ) (in prosieguo anche: l’«ordinanza impugnata») in quanto irricevibile. Il Tribunale ha motivato la sua decisione sostenendo non da ultimo che il regolamento n. 1007/2009 è un atto legislativo che non può essere inteso come atto regolamentare nell’accezione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti (in prosieguo anche: i «ricorrenti») – ad eccezione di uno di essi ( 9 ) – contestano la suddetta ordinanza con il presente mezzo di impugnazione.
II – Le disposizioni dell’Unione in materia di immissione in commercio dei prodotti derivati dalla foca
6.
Le disposizioni dell’Unione in materia di immissione in commercio dei prodotti derivati dalla foca nel mercato interno europeo si trovano in parte in un regolamento di base adottato dal Parlamento e dal Consiglio nel 2009 (regolamento n. 1007/2009), in parte in un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione nel 2010 (regolamento n. 737/2010). Nel presente procedimento è controversa solo la legittimazione ad agire della Inuit Tapiriit Kanatami e degli altri ricorrenti contro il regolamento di base, mentre il regolamento di esecuzione è oggetto di un distinto ricorso, presentato dai suddetti ricorrenti e ancora pendente dinanzi al Tribunale ( 10 ).
A – Il regolamento di base (regolamento n. 1007/2009)
7.
L’oggetto del regolamento n. 1007/2009 è determinato nel seguente modo all’articolo 1:
«Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca».
8.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1007/2009 sono applicabili le seguenti «condizioni per l’immissione in commercio» di prodotti derivati dalla foca:
«1. L’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
l’importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l’importazione possa avere finalità commerciali;
b)
l’immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l’immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.
L’applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
3. La Commissione, secondo la procedura di gestione (...), predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, le misure per l’attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo (...)».
9.
All’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 1007/2009, inoltre, è contenuta la seguente definizione di «Inuit»:
«i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia)».
B – Il regolamento di esecuzione (regolamento n. 737/2010)
10.
Sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1007/2009 la Commissione ha emanato, il 10 agosto 2010, modalità di applicazione in materia di commercio di prodotti derivati dalla foca sotto forma del regolamento (UE) n. 737/2010 ( 11 ) (in prosieguo anche: il «regolamento di esecuzione»).
11.
L’articolo 1 del regolamento n. 737/2010 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le modalità di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009».
12.
All’articolo 3 del regolamento n. 737/2010 sono stabilite le condizioni che devono essere soddisfatte affinché i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata da comunità Inuit o da altre comunità indigene possano essere immessi sul mercato.
13.
L’articolo 4 del regolamento n. 737/2010 fissa le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca destinati all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari possono essere importati.
14.
L’articolo 5 del regolamento n. 737/2010 disciplina infine le condizioni alle quali i prodotti derivati dalla foca ottenuti nell’ambito della gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato.
III – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
15.
Con atto introduttivo del 21 novembre 2011 la Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti hanno presentato la presente impugnazione. Essi chiedono di
—
annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento, qualora la Corte consideri presenti tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso di annullamento del regolamento controverso;
—
in subordine, annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese sostenute dai ricorrenti; nonché
—
condannare la Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi a sopportare le proprie spese.
16.
Il Parlamento chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare i ricorrenti alle spese.
17.
Il Consiglio chiede:
—
il rigetto dell’impugnazione e
—
la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese.
18.
Anche la Commissione, che aveva sostenuto come interveniente il Parlamento e il Consiglio già in prime cure, chiede alla Corte di giustizia di respingere l’impugnazione e di condannare i ricorrenti a sostenere le spese.
19.
Il Regno dei Paesi Bassi, che invece aveva del pari sostenuto come interveniente il Parlamento e il Consiglio in prime cure, non è intervenuto nel procedimento dinanzi alla Corte.
20.
Dinanzi alla Corte di giustizia si è svolta una fase scritta e, il 20 novembre 2012, un’udienza.
IV – Valutazione
21.
L’interpretazione e l’applicazione della legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma TFUE, rivestono un’importanza fondamentale per la realizzazione di una tutela giurisdizionale effettiva. Esse, tuttavia, hanno anche effetti significativi sulla delimitazione della competenza e delle attribuzioni fra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali. In termini estremamente generali si può affermare che esse rivestono un’importanza che non può essere sottovalutata nel sistema generale di tutela delineato nei Trattati europei.
22.
Tutte le parti del presente procedimento di impugnazione sono concordi nel sostenere che con l’articolo 263, quarto comma, TFUE è stata ampliata la legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche. Fra di esse, tuttavia, è estremamente controversa l’entità di tale ampliamento. Le parti hanno conseguentemente opinioni molto divergenti circa la corretta interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
23.
Mentre le tre istituzioni dell’Unione che sono parti nel procedimento – Parlamento, Consiglio e Commissione – difendono chiaramente e ampiamente l’ordinanza del Tribunale impugnata con i medesimi argomenti, i ricorrenti assumono una posizione diametralmente opposta; essi ritengono che il Tribunale abbia interpretato in modo troppo restrittivo l’articolo 263, quarto comma, TFUE e, pertanto, abbiano trascurato i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
24.
In particolare, i ricorrenti presentano complessivamente tre motivi per impugnare l’ordinanza del Tribunale, di cui il primo è dedicato al disposto dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in quanto tale (v., in proposito, infra, sezione A), mentre il secondo riguarda il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo (v., in proposito, infra, sezione B) e il terzo affronta la questione se il Tribunale abbia interpretato correttamente la domanda presentata dai ricorrenti in prime cure (v., in proposito, infra, sezione C).
A – Primo motivo
25.
Il primo motivo rappresenta il baricentro della presente controversia. In questo contesto fra le parti vi è disaccordo su quale siano la corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che, nella sua versione ancora in vigore, è basata sul Trattato di Lisbona e ha il seguente tenore:
«qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
1. L’espressione «atto regolamentare» (prima parte del primo motivo)
26.
Con la prima parte del primo motivo, diretto contro i punti 38‑56 dell’ordinanza impugnata, i ricorrenti contestano al Tribunale un’interpretazione e un’applicazione errate della locuzione «atto regolamentare» nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
27.
La pietra dello scandalo per la Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti è rappresentata dal fatto che il Tribunale nella sua ordinanza non consideri gli atti legislativi di cui all’articolo 289, terzo comma, TFUE ( 12 ) – fra cui è annoverabile anche il controverso regolamento n. 1007/2009 – come atti regolamentari. La tesi giuridica criticata dai ricorrenti è precisata al punto 56 dell’ordinanza impugnata, in cui il Tribunale afferma che
«la nozione di “atto regolamentare” ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi. Di conseguenza, un atto legislativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica unicamente se la riguarda direttamente e individualmente».
I ricorrenti vi vedono un’applicazione eccessivamente restrittiva delle possibilità di azione dei singoli. Ai loro occhi la distinzione fra atti legislativi e atti non aventi natura di legge appare eccessivamente formalistica. Per contro le istituzioni dell’Unione che sono parti nel procedimento – Parlamento, Consiglio e Commissione – ritengono corretta la soluzione cui è pervenuto il Tribunale e la difendono con forza.
28.
Anche in dottrina il dibattito sull’interpretazione della nuova terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è estremamente controverso. Mi sembra che, in proposito, coloro che sono a favore di un’inclusione degli atti legislativi nella categoria degli atti regolamentari bilancino più o meno coloro che bocciano tale tesi ( 13 ).
29.
Come esporrò in seguito, l’interpretazione adottata dal Tribunale della locuzione «atti regolamentari» è corretta [v. in proposito, a seguire, sezione a)], mentre gli argomenti di segno contrario esposti dai ricorrenti non risultano convincenti [v. in proposito, infra, sezione b)].
a) L’interpretazione data dal Tribunale alla nozione di «atti regolamentari»
30.
La nozione di «atto regolamentare» non è definita in alcun punto dei Trattati. Come sottolinea giustamente il Tribunale, è certo che si dovrà sempre trattare di atti giuridici europei di portata generale ( 14 ). Ciò però non significa necessariamente che tutti gli atti giuridici europei di portata generale siano allo stesso tempo atti regolamentari.
31.
In particolare sarebbe avventato presumere che tutti i regolamenti siano allo stesso tempo atti regolamentari, a prescindere che si tratti di atti legislativi o no. Pur essendo innegabile, in alcune versioni linguistiche dei Trattati, una certa somiglianza tra la nozione di «regolamento» ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE e quella di «atto regolamentare» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 15 ), se si equiparassero le nozioni di «regolamento» e «atto regolamentare» sulla base selettiva di alcune versioni linguistiche del TFUE si trascurerebbe il fatto che i Trattati europei sono ormai ugualmente vincolanti in 23 lingue diverse (articolo 55, paragrafo 1, TUE, e articolo 358 TFUE). In molte lingue ufficiali dell’Unione non si può affatto parlare di affinità etimologica tra le nozioni di «regolamento» e di «atto regolamentare» ( 16 ).
32.
Date queste premesse, si deve muovere dal presupposto che l’espressione «atto regolamentare» sia una nozione di diritto europeo sui generis, per interpretare la quale si dovrà tener conto tanto della finalità della disposizione interessata del Trattato, quanto del contesto in cui si inserisce ( 17 ) e della sua genesi. Certo, finora la genesi in particolare non ha svolto alcun ruolo nell’interpretazione del diritto primario perché gran parte dei travaux préparatoires dei Trattati istitutivi non era disponibile. Quest’ambito è stato però radicalmente trasformato dalla prassi di insediare convenzioni incaricate di preparare le modifiche ai Trattati e da quella di rendere pubblici i mandati delle conferenze intergovernative. La maggiore trasparenza nella fase che precede le modifiche ai Trattati apre nuove possibilità per la loro interpretazione. Queste non dovrebbero restare inutilizzate come strumento integrativo allorché, come in questo caso, il significato di una norma continui a essere oscuro dopo che se ne siano considerati la lettera, il contesto e la finalità perseguita ( 18 ).
33.
La riformulazione dell’ex articolo 230, quarto comma, CE da parte del vigente articolo 263, quarto comma, TFUE aveva indubbiamente per finalità di estendere la tutela dei diritti individuali ampliando le possibilità delle persone fisiche e giuridiche di esperire ricorso contro gli atti giuridici di portata generale dell’Unione ( 19 ). Se considerata di per sé, tale finalità conforta un’interpretazione estensiva della nozione di «atti regolamentari» ( 20 ).
34.
Va tuttavia ricordato che gli estensori del Trattato di Lisbona hanno ottenuto lo scopo di rafforzare la tutela dei diritti individuali non solo ampliando per le persone fisiche e giuridiche le possibilità di ricorso diretto ai sensi della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma anche perseguendo in parallelo, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il rafforzamento della tutela dei diritti individuali offerta dai giudici nazionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.
35.
La lettura congiunta dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE permette di concludere che le possibilità del singolo di ottenere tutela giurisdizionale contro gli atti giuridici dell’Unione di portata generale non devono necessariamente sempre consistere nella facoltà di adire direttamente i giudici dell’Unione.
36.
Il fatto che vi siano differenze specialmente nei requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento, a seconda che quest’ultimo abbia ad oggetto un atto legislativo oppure un atto regolamentare, emerge peraltro dal combinato disposto dei diversi paragrafi dell’articolo 263 TFUE. Il primo tratta di «atti legislativi» mentre il quarto, che qui interessa, fa riferimento ad «atti regolamentari». Queste differenze di scelta terminologica, che non si possono ritenere casuali, sono piuttosto espressione del fatto che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, alle diverse categorie di ricorrenti spettano da sempre possibilità di ricorso diretto di portata diversa.
37.
Mentre i ricorrenti privilegiati, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e i ricorrenti che lo sono parzialmente, ai sensi dell’articolo 263, terzo comma, TFUE sono legittimati a proporre ricorso contro tutti i tipi di atti dell’Unione citati nel primo comma, atti legislativi inclusi, la legittimazione attiva diretta delle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE è da sempre limitata a determinati tipi di atti dell’Unione. Una possibilità di ricorso semplificato è concessa dalla terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE solo contro gli atti regolamentari e non contro gli atti legislativi. Come evidenzia correttamente il Tribunale, anche in futuro i singoli potranno impugnare direttamente atti legislativi solo in via eccezionale e nell’ambito della seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE cioè a condizione che l’atto legislativo li riguardi direttamente e individualmente ( 21 ).
38.
Il fatto che al singolo non siano date possibilità semplificate per ricorrere direttamente contro gli atti legislativi è spiegabile in particolare con la legittimità democratica particolarmente forte della legislazione parlamentare. Di conseguenza, la distinzione tra atti legislativi e non legislativi sotto il profilo della tutela giurisdizionale non può essere liquidata come mero formalismo e si fonda invece su una distinzione qualitativa. In molti ordinamenti nazionali le possibilità di ricorso diretto dei singoli contro le leggi approvate dal Parlamento sono inesistenti o limitate.
39.
Il fatto che a tutt’oggi nel sistema dei Trattati europei non siano attribuite ai singoli possibilità di ricorso semplificate contro gli atti legislativi trova conferma se si include nelle riflessioni la genesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Questa norma, che risale ai lavori della Convenzione europea, in origine doveva far parte del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa ( 22 ) («Trattato costituzionale»), come articolo III‑365, quarto comma.
40.
In virtù dei suoi articoli da I‑33 a I‑37, il Trattato costituzionale poggiava su una distinzione e un’articolazione gerarchica chiare tra atti legislativi e non legislativi, nel cui ambito il «regolamento europeo» era classificabile esclusivamente nella seconda categoria in quanto «atto non legislativo di portata generale» (articolo I‑33, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del Trattato costituzionale). Se quindi l’articolo III‑365, paragrafo 4, del Trattato costituzionale trattava della possibilità per le persone fisiche e giuridiche di ricorrere contro gli «atti regolamentari», era manifesto che ciò riguardasse solo gli atti non legislativi. Ciò è confermato anche dai documenti della Convenzione europea relativi all’articolo III‑270, paragrafo 4, del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa ( 23 ), cioè la norma che poi si è ritrovata nel Trattato costituzionale come articolo III‑365, paragrafo 4. Secondo tali documenti la formulazione «atti giuridici di portata generale», pur essendo stata discussa dalla Convenzione, alla fine è stata scartata e sostituita definitivamente dalla nozione meno ampia di «atti regolamentari», destinata a esprimere la distinzione tra atti legislativi e non legislativi ( 24 ).
41.
Il fatto che, in quasi tutte le versioni linguistiche ( 25 ), il testo dell’articolo III‑365, paragrafo 4, del Trattato costituzionale sia stato ripreso alla lettera dal Trattato di Lisbona porta a concludere che anche nell’attuale articolo 263, quarto comma, TFUE non si intendano gli atti legislativi laddove si parla di atti regolamentari. Ciò trova chiara espressione soprattutto nelle numerose versioni linguistiche del Trattato FUE in cui, per individuare gli «atti regolamentari», si ricorre a una formulazione che fa pensare all’emanazione di norme da parte non tanto dell’organo legislativo quanto dell’organo esecutivo ( 26 ).
42.
Il Trattato di Lisbona certo non sistematizza né articola gerarchicamente gli atti giuridici dell’Unione in modo paragonabile al Trattato costituzionale. Nel sistema del Trattato UE e del Trattato FUE gli atti legislativi possono assumere anche la forma di regolamenti, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, TFUE. Attualmente la distinzione tra atti legislativi e non legislativi ha un significato per lo più procedurale, per esempio negli articoli 290, primo comma, e 297 TFUE.
43.
Stanti tali differenze tra il Trattato costituzionale e i Trattati oggi in vigore, si potrebbe teoricamente ipotizzare di attribuire un significato diverso alla nozione di «atti regolamentari» di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE – in linea con la proposta dei ricorrenti – e di intenderla in senso più ampio di quanto non fosse nelle intenzioni della Convenzione europea e degli estensori del Trattato costituzionale, in modo da poter annoverare tra gli atti regolamentari anche gli atti legislativi.
44.
Tale interpretazione estensiva della nozione di «atti regolamentari» sarebbe però difficile da conciliare con il mandato della Conferenza intergovernativa del 2007 che ha negoziato il Trattato di Lisbona. Tale Conferenza era incaricata da un lato di abbandonare il progetto di Costituzione su cui poggiava il Trattato costituzionale ( 27 ) e per il resto di non rimettere in questione ciò che si era ottenuto con la firma del Trattato ( 28 ). Il contenuto del «prodotto finale» della Conferenza intergovernativa doveva quindi corrispondere per quanto possibile al mancato Trattato costituzionale e se ne doveva discostare per difetto solo in alcuni punti particolarmente simbolici ( 29 ).
45.
Ai fini del procedimento di specie va evidenziato in particolare che, secondo il mandato della Conferenza intergovernativa del 2007, andava mantenuta «ferma (…) la distinzione tra atti legislativi e non legislativi e relative conseguenze» ( 30 ).
46.
Date le premesse è altamente improbabile, né esiste un qualsiasi indizio concreto in tal senso, che la Conferenza intergovernativa intendesse andare oltre il Trattato costituzionale, nello specifico con l’articolo 263, quarto comma, TFUE. Oltretutto ci si sarebbe dovuti attendere dagli estensori del Trattato di Lisbona che avrebbero reso riconoscibile un ampliamento delle possibilità di ricorso dei singoli, rispetto all’articolo III‑365, paragrafo 4, del Trattato costituzionale, nella formulazione di tutte le versioni linguistiche dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 31 ), per esempio impiegando la nozione di «atti di portata generale» discussa nella Convenzione europea ma alla fine in tal sede scartata ( 32 ). Tanto più che quest’ultima formulazione è di uso assai corrente in altri punti del TFUE (v. articolo 277 TFUE; articolo 288, secondo comma, prima frase, TFUE, e articolo 290, primo comma, TFUE).
47.
Nel complesso, pertanto, il Tribunale ha avuto pienamente ragione a interpretare la nozione di «atti regolamentari» nel senso di comprendervi tutti gli atti giuridici dell’Unione di portata generale tranne gli atti legislativi.
b) Le controargomentazioni avanzate dai ricorrenti
48.
Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, l’interpretazione e l’applicazione della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, realizzate dal Tribunale nella fattispecie, non determinano assolutamente lo svuotamento della legittimazione ad agire delle persone fisiche e giuridiche avverso gli atti regolamentari, privando così l’innovazione introdotta dal Trattato di Lisbona della sua raison d’être. È invece l’argomentazione degli stessi ricorrenti a essere gravata da seri difetti, fondati, da un lato, su un modo errato di leggere l’ordinanza impugnata e, dall’altro, su un’errata comprensione di fondo delle procedure e degli atti giuridici previsti dai Trattati.
– Non tutti i regolamenti, né tutte le direttive e le decisioni, sono atti legislativi
49.
In primo luogo, i ricorrenti contestano al Tribunale il fatto che l’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che quest’ultimo predilige, porterebbe a includere nella nozione di atti regolamentari solo le raccomandazioni e i pareri di cui all’articolo 288, quinto comma, TFUE – comunque non impugnabili – in quanto le direttive, le decisioni e i regolamenti adottati dal Parlamento e dal Consiglio sarebbero senza eccezioni atti legislativi.
50.
Quest’argomentazione è sbagliata. Ovviamente vi sono altri atti giuridici dell’Unione, oltre alle raccomandazioni e ai pareri, che sono classificabili come atti regolamentari, in particolare numerosi regolamenti di cui all’articolo 288, secondo comma, TFUE, e numerose decisioni di cui all’articolo 288, quarto comma, TFUE. Nella pratica si tratta addirittura della stragrande maggioranza dei casi, come hanno fatto giustamente notare il Consiglio e la Commissione.
51.
I ricorrenti dimenticano che, pur rientrando i regolamenti e le decisioni, come anche le direttive, nelle tipologie di atti giuridici adottabili con procedura legislativa (articolo 289, paragrafi 1 e 2, TFUE), solo un numero di gran lunga inferiore di questi atti dell’Unione è posto in essere con tale procedura. Anche atti non legislativi possono assumere la forma di regolamenti, direttive o decisioni (articolo 297, paragrafo 2, TFUE).
52.
In particolare, in molti casi il Consiglio o la Commissione adottano regolamenti per dare esecuzione ad atti legislativi oppure nel quadro di una procedura sui generis ( 33 ). Nel caso delle decisioni, è addirittura la regola che siano adottate con procedure diverse da quella legislativa, per lo più dal Consiglio o dalla Commissione, e che poi siano eventualmente considerate atti regolamentari, tanto più se non si rivolgono a destinatari designati (articolo 288, quarto comma, seconda frase, TFUE, con interpretazione a contrario).
– Non tutti gli atti non legislativi sono atti delegati
53.
In secondo luogo, i ricorrenti argomentano che gli estensori del Trattato di Lisbona avrebbero parlato non già di «atti regolamentari» bensì di «atti delegati», ai sensi dell’articolo 290 TFUE, nel caso in cui avessero ambito a distinguere tra atti legislativi e non legislativi nell’articolo 263, quarto comma, TFUE. L’impiego della nozione «atti regolamentari» denoterebbe secondo i ricorrenti che si intende qualcosa di diverso dagli atti non legislativi.
54.
Neanche questo argomento convince. I ricorrenti non si rendono conto che non tutti gli atti non legislativi devono necessariamente essere atti delegati di cui all’articolo 290 TFUE. Possono anche assumere la forma di atti di esecuzione di cui all’articolo 291 TFUE oppure essere adottati con procedura sui generis ( 34 ).
– Anche gli atti di esecuzione possono essere atti regolamentari
55.
In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che, dopo la distinzione operata dal Tribunale tra atti legislativi e non legislativi, non si saprebbe più dove classificare la categoria degli atti di esecuzione di cui all’articolo 291 TFUE.
56.
Anche quest’affermazione è errata. Come si è accennato ( 35 ), gli atti di esecuzione di cui all’articolo 291 TFUE possono rientrare senza difficoltà nella categoria degli atti non legislativi. Allorché tali atti di esecuzione hanno portata generale, come avviene di norma per i regolamenti di esecuzione e spesso per le decisioni di esecuzione, devono essere considerati atti regolamentari.
– Gli effetti dell’articolo 263, quarto comma, TFUE sui casi come Unión de Pequeños Agricultores e Jégo‑Quéré
57.
I ricorrenti affermano infine che un’interpretazione e un’applicazione della legittimazione attiva come quelle che pratica il Tribunale non sarebbero idonee a colmare le «lacune nella tutela giurisdizionale» constatate nei casi Unión de Pequeños Agricultores ( 36 ) e Jégo‑Quéré ( 37 ).
58.
Neanche quest’affermazione coglie nel segno.
59.
Nella causa Jégo‑Quéré era oggetto del ricorso di annullamento un regolamento esecutivo della Commissione riguardante il settore della pesca. Oggi, nell’ambito di validità temporale dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un atto del genere andrebbe considerato un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.
60.
Nella causa Unión de Pequeños Agricultores, invece, era oggetto di ricorso un’organizzazione comune di mercato nel settore della politica agricola. Oggi un regolamento del genere andrebbe adottato con procedura legislativa ordinaria (articolo 43, paragrafo 2, TFUE) e rappresenterebbe quindi un atto legislativo (articolo 289, paragrafo 3, TFUE). Anche ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dunque, non vi sarebbe alcuna possibilità per le persone fisiche e giuridiche di ricorrere contro tale regolamento direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione, a meno che quest’ultimo non le riguardi direttamente e, soprattutto, individualmente (seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE). Naturalmente ciò non vuol dire che i singoli non possano ottenere una tutela giurisdizionale effettiva contro le disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato, ma che è loro facoltà eccepire l’eventuale illegittimità di un’organizzazione comune di mercato in via incidentale. A seconda della natura della causa, lo potranno fare nel quadro di ricorsi di annullamento proposti dinanzi ai giudici dell’Unione contro misure di esecuzione della Commissione, oppure di rimedi giurisdizionali promossi dinanzi a giudici interni contro misure di esecuzione assunte da organi nazionali ( 38 ).
61.
A mero titolo di annotazione a margine, anche nel caso di specie la Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti non sono privati della tutela giurisdizionale dall’interpretazione che il Tribunale effettua della nozione di «atti regolamentari» di cui alla terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Hanno invece facoltà di eccepire la presunta illegittimità del regolamento n. 1007/2009 in via incidentale, cioè nel quadro di controversie eventualmente promosse contro misure di esecuzione relative a quel regolamento. È appunto ciò che la maggior parte di loro ha fatto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea in occasione di un ricorso ancora pendente contro il regolamento di esecuzione n. 737/2010 della Commissione ( 39 ).
62.
Tutto sommato, pertanto, la prima parte del primo motivo è priva di fondamento.
2. La questione dell’interesse diretto e individuale dei ricorrenti (seconda parte del primo motivo)
63.
Poiché, secondo la soluzione da me proposta, la prima parte del primo motivo non ha prospettive di successo, va ora analizzata la seconda parte di tale motivo, fatta valere in subordine, con la quale i ricorrenti eccepiscono l’erronea interpretazione e applicazione, da parte del Tribunale, del requisito di ricevibilità dell’«interesse diretto e individuale».
64.
Il criterio dell’interesse diretto e individuale (seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE) è volto a procurare alle persone fisiche e giuridiche una tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti giuridici dell’Unione non indirizzati a loro senza però estendere al contempo il campo di applicazione del ricorso di annullamento al punto di farne una sorta di azione popolare (actio popularis).
65.
Il Tribunale si è soffermato sul suddetto criterio nei punti 68‑93 dell’ordinanza impugnata, dopo essere giunto alla conclusione che la Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti non potevano impugnare il regolamento n. 1007/2009, che è un atto legislativo ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE alle condizioni semplificate vigenti per gli atti regolamentari (terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE).
a) L’interesse diretto dei ricorrenti
66.
I ricorrenti si oppongono in primo luogo all’opinione del Tribunale secondo cui solo quattro tra loro sarebbero direttamente interessati dal regolamento controverso, ovvero Ta Ma Su Seal Products, NuTan Furs, GC Rieber Skinn e Canadian Seal Marketing Group ( 40 ); stando ai fatti accertati dal Tribunale, si tratta in quei casi di tre imprese e di un consorzio imprenditoriale attivi nel commercializzare prodotti derivati dalla foca e di altro tipo nel mercato interno europeo.
67.
I ricorrenti eccepiscono l’interpretazione troppo restrittiva che il Tribunale avrebbe dato in tal modo al criterio dell’interesse diretto. A loro giudizio vanno considerati direttamente interessati dal regolamento controverso anche i ricorrenti che operano solo nella fase che precede la commercializzazione di prodotti derivati dalla foca nel mercato unico europeo, cioè non solo chi caccia e cattura foche e le loro associazioni di rappresentanza, ma anche la ricorrente Karliin Aariak, che si occupa di creare e vendere abiti confezionati con pelli di foca.
– Osservazioni preliminari
68.
Occorre tener presente, in via introduttiva, che il criterio dell’interesse diretto, contenuto nell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non può essere interpretato in modo più restrittivo di quello, dalla formulazione identica, contenuto nelle previgenti norme dell’articolo 173, quarto comma, del Trattato C(E)E e dell’articolo 230, quarto comma, CE ( 41 ). I ricorrenti lo hanno giustamente fatto notare e anche le istituzioni parti nel procedimento non lo hanno messo in dubbio.
69.
La nozione di interesse diretto è la stessa nella seconda e nella terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Quanto espongo di seguito, di conseguenza, varrebbe anche nel caso in cui la Corte, non accogliendo la mia proposta, dovesse classificare il regolamento controverso tra gli atti regolamentari ( 42 ).
70.
Per definire i requisiti giuridici perché vi sia interesse diretto, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale è ricorso a una formula adoperata spesso nella giurisprudenza recente dei giudici dell’Unione ( 43 ). Secondo tale formula, la condizione secondo la quale l’atto giuridico dell’Unione deve incidere direttamente sulla persona fisica o giuridica è soddisfatta solo se l’atto contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di quest’ultima e se esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie ( 44 ).
71.
Nutro qualche dubbio sulla reale idoneità di tale formula a descrivere in via definitiva il criterio dell’interesse diretto di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Da una parte, infatti, sono ripetutamente ammessi in giurisprudenza – e con piena ragione – ricorsi di annullamento proposti da singoli contro atti giuridici dell’Unione che producono su di loro effetti di natura non giuridica ma semplicemente reale, ad esempio perché incidono direttamente sulla loro qualità di operatori di mercato in concorrenza con altri operatori ( 45 ). D’altra parte sono noti casi di giurisprudenza in cui l’interesse diretto di un soggetto è stato riconosciuto anche in presenza di un certo potere discrezionale degli organismi competenti per l’attuazione dell’atto giuridico dell’Unione, purché si potesse ritenere sufficientemente probabile che tale discrezionalità sarebbe stata esercitata in un determinato modo ( 46 ).
72.
In ogni caso, queste sfumature nella formulazione del criterio dell’interesse diretto non fanno alcuna differenza per il caso di specie. Infatti, anche quando si muova dal presupposto che, nell’ambito della seconda ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, vanno considerati non solo gli effetti dell’atto giuridico dell’Unione sulla situazione giuridica del soggetto, ma anche i suoi effetti di natura reale su quest’ultimo, comunque tali effetti non potranno essere solo di tipo indiretto. Concretamente, ciò va determinato caso per caso con riguardo al contenuto normativo dello specifico atto giuridico dell’Unione contestato.
– La situazione dei soggetti che operano nei segmenti a monte della filiera
73.
Nel caso di specie il regolamento n. 1007/2009 contiene, come risulta dal suo articolo 1, «norme armoniz