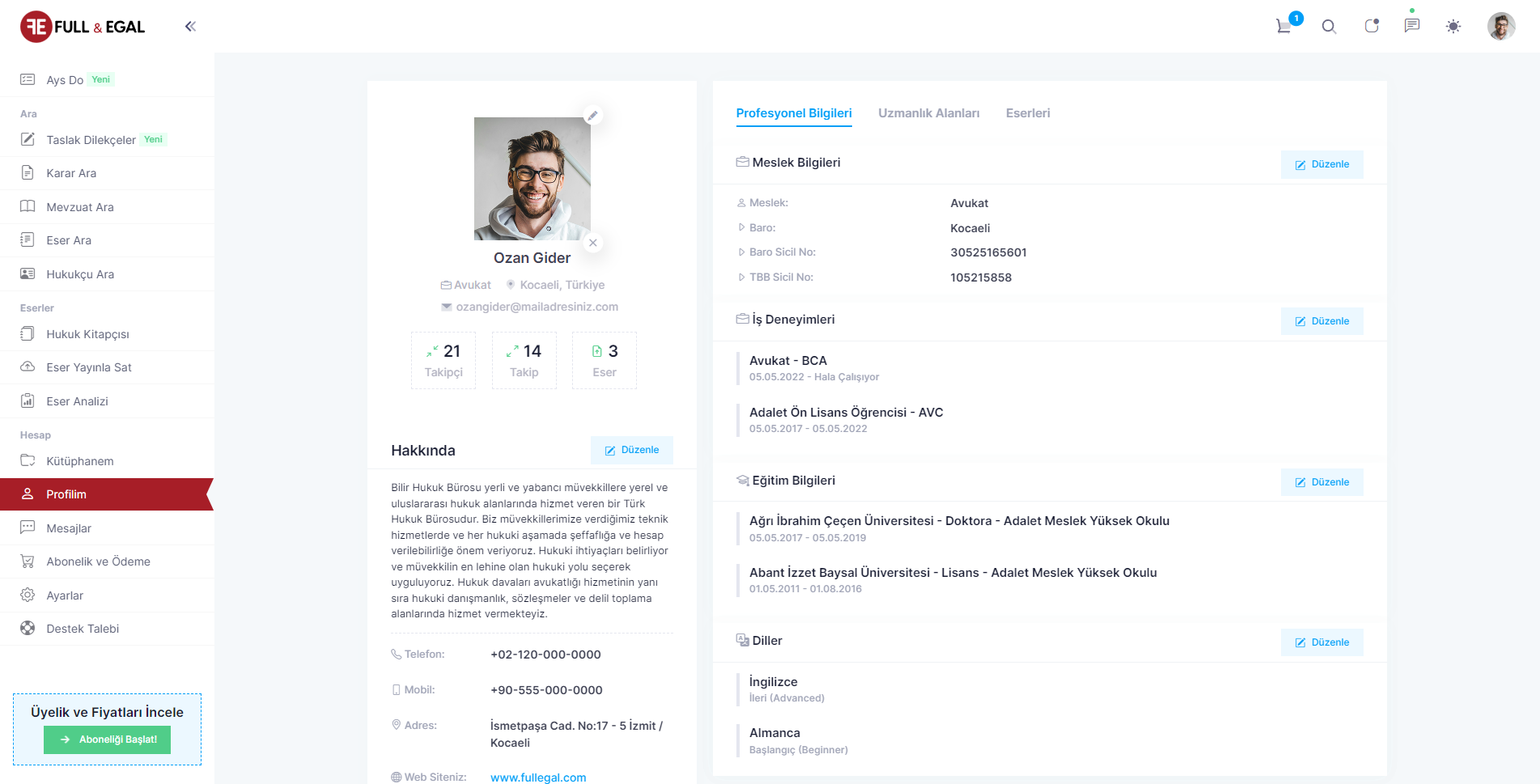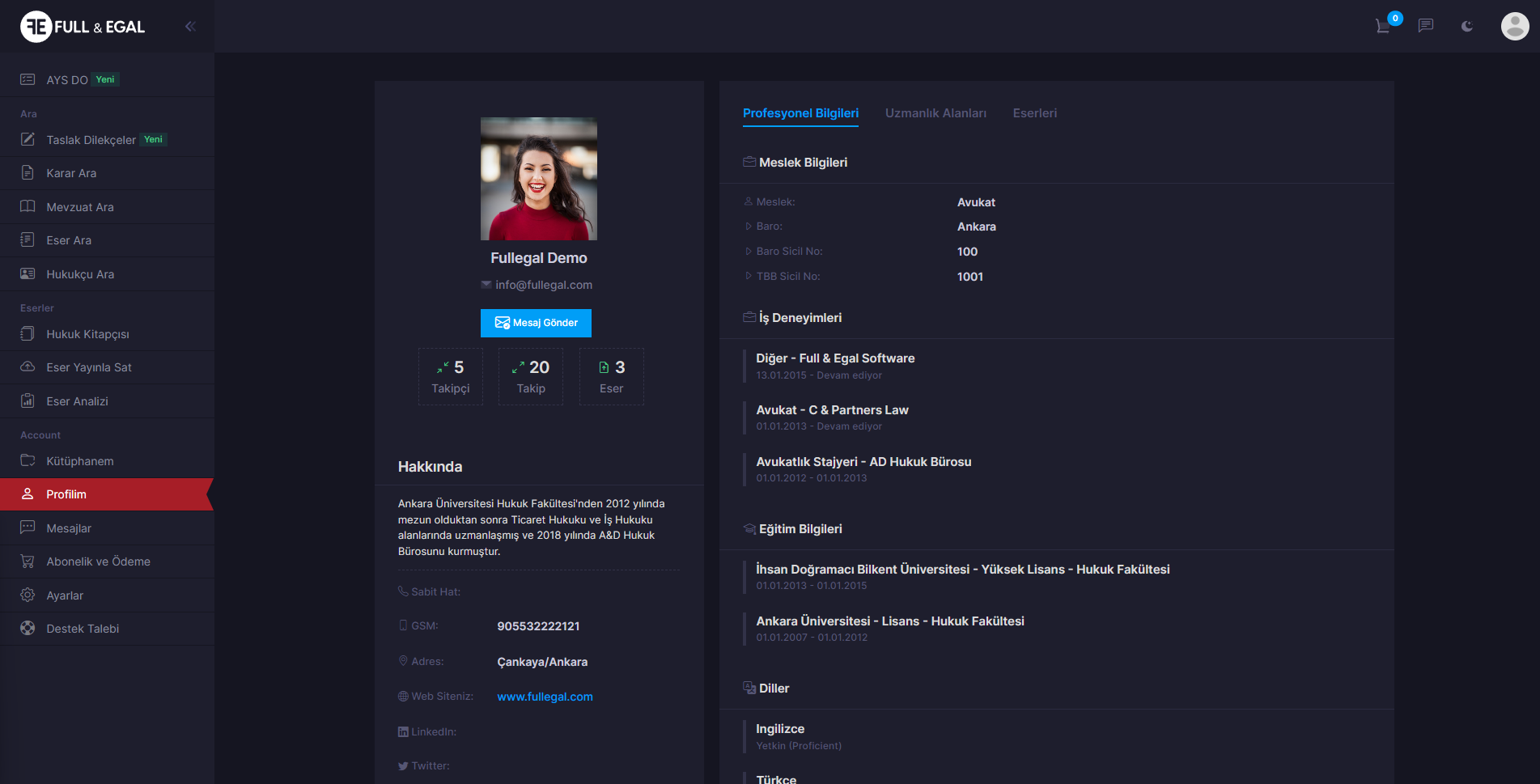© Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 61781/08
Giuseppe TORNO e altri contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 23 settembre 2014 in una Camera composta da:
Işıl Karakaş, presidente,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, giudici,
e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
visto il ricorso sopra menzionato proposto il 17 dicembre 2008,
dopo aver deliberato, decide:
IN FATTOI ricorrenti, i sigg. Giuseppe Torno, Ettore Giovanni Torno e Alberto Torno, sono cittadini italiani. Essi sono nati rispettivamente negli anni 1963, 1964 e 1966, e vivono a Milano. Sono stati rappresentati dinanzi alla Corte dagli avv.ti Giorgio De Nova, Daniele Maffeis e Vittorio Pellegatta, del foro di Milano.
A. Le circostanze del caso di specieIn data 10 febbraio 1981 il Ministero dei beni culturali e ambientali agì in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti del padre dei ricorrenti e dei suoi fratelli, sostenendo che diversi reperti archeologici, di epoca romana, greca ed etrusca, che si trovavano nella casa di famiglia dei convenuti, rientravano nella definizione di patrimonio indisponibile dello Stato.Con sentenza del 10 marzo 1986 il Tribunale di Milano respinse l’azione, ritenendo che, poiché il principio della proprietà statale dei beni archeologici era stato stabilito per la prima volta dalla legge n. 364 del 20 giugno 1909, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che il possesso da parte dei convenuti fosse illegittimo, ovvero che il materiale archeologico in questione provenisse da scavi effettuati successivamente all’entrata in vigore della summenzionata legge.Il Ministero impugnò la decisione, affermando che l’applicazione del principio generale “possideo quia possideo” all’ambito di beni del patrimonio archeologico (vale a dire il riconoscimento del fatto che il possesso fattuale da parte dei convenuti fosse sufficiente a provare il loro diritto di proprietà) equivaleva a una probatio diabolica [prova impossibile] per lo Stato, mentre per i convenuti – che dovevano conoscere l’origine del loro patrimonio – l’onere di produrre la prova della legittimità del loro possesso, ovvero che i beni in questione provenivano da scavi effettuati anteriormente alla promulgazione della summenzionata legge, era perfettamente fattibile. A ogni modo il Ministero obiettò di aver prodotto tale prova poiché le perizie tecniche esaminate nel corso del processo avevano dimostrato l’illegittimità del possesso da parte dei ricorrenti di due reperti archeologici, ed era indiscusso che il padre dei convenuti avesse messo insieme la sua collezione tra gli anni trenta e gli anni sessanta del secolo scorso, assai dopo l’entrata in vigore della legge n. 364 del 20 giugno 1909.Il 10 novembre 1992 la Corte di appello di Milano respinse l’appello del Ministero, eccetto che per i due reperti summenzionati che erano stati incontestatamente scoperti dopo il 1909 e che furono pertanto dichiarati di proprietà dello Stato.Il 2 ottobre 1995 la Corte di cassazione annullò la decisione e rinviò la causa alla Corte di appello, per un nuovo processo, ritenendo che la legislazione applicabile (la legge n. 364 del 20 giugno 1909, la legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e gli articoli 826, comma 2, e 840 del codice civile) confermasse un principio già esistente nell’ordinamento giuridico, ovvero l’assunto che, in generale, i reperti archeologici facessero parte del patrimonio dello Stato. Pertanto, poiché la proprietà privata dei resistenti era un’eccezione piuttosto che la regola, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile spettava a loro e non al Ministero ricorrente dimostrare la legittimità del possesso dei beni in questione, in particolare che essi erano stati scoperti e acquisiti prima della promulgazione della legge n. 364 del 20 giugno 1909. Tale principio fu seguito nelle successive sentenze sulla questione (si veda Il diritto e la prassi interni, infra, paragrafo 20).Il 18 aprile 1999 il padre dei ricorrenti decedette ed essi manifestarono l’intenzione di proseguire il procedimento in qualità di eredi.Il 20 dicembre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarò che i reperti erano di proprietà dello Stato e ingiunse ai convenuti di restituire i beni archeologici al ricorrente.I ricorrenti presentarono ricorso per motivi di diritto avverso la suddetta decisione, ma esso fu respinto dalla Corte di cassazione il 5 agosto 2008. La Corte osservò in particolare che l’interpretazione delle norme che disciplinavano l’onere della prova nel caso dei ricorrenti non era né sproporzionata né irragionevole, specialmente alla luce del pubblico interesse alla conservazione del materiale artistico, storico e archeologico. Inoltre, a differenza di quanto asserito dai ricorrenti, la suddetta interpretazione non costituiva un esproprio di fatto senza indennizzo poiché non violava il diritto di accesso a un tribunale né il diritto di difesa nei procedimenti relativi ai beni in questione.In risposta a una richiesta della Corte, il 15 gennaio 2014, i ricorrenti hanno dichiarato che, nonostante una formale notifica emessa il 23 gennaio 2009 seguita da un inventario dei reperti in questione, la sentenza della Corte di cassazione del 5 agosto 2008 non era stata ancora eseguita.
B. Il diritto e la prassi interni pertinenti
1. La legge n. 364 del 20 giugno 1909
Questa legge disciplina lo status delle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, e afferma il principio generale della loro inalienabilità se esse possono essere classificate come patrimonio dello Stato.Essa stabilisce anche diverse limitazioni al libero uso di tali cose qu